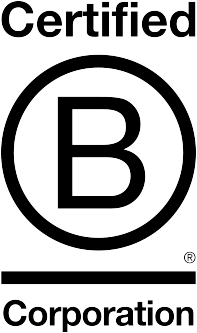La legge italiana sullo spazio è realtà: autorizzazioni, controlli e responsabilità.

Con la legge 13 giugno 2025, n. 89, l’Italia si dota per la prima volta di un quadro normativo completo per regolamentare le attività spaziali. Il provvedimento, atteso da anni e ispirato a una logica di presidio strategico, disciplina l’accesso allo spazio extra-atmosferico da parte di operatori pubblici e privati, nazionali ed esteri, colmando un vuoto normativo e rafforzando il ruolo dell’Italia dal punto di vista europeo e internazionale. La legge regola l’intero ciclo di vita delle attività spaziali, dalla fase di lancio e messa in orbita di satelliti alla gestione in orbita, fino al rientro e smaltimento, includendo anche le attività di produzione nello spazio, estrazione di risorse da corpi celesti e utilizzo di piattaforme stratosferiche. Al centro del sistema si colloca l’obbligo di autorizzazione preventiva, corredato da requisiti stringenti in materia di sicurezza, resilienza informatica, sostenibilità ambientale e copertura assicurativa.
Tuttavia, questa nuova architettura normativa dovrà ora confrontarsi con la proposta di Regolamento europeo sulle attività spaziali (EU Space Act), presentata dalla Commissione UE il 25 giugno 2025. Il testo europeo punta, infatti, a unificare le regole per l’autorizzazione, l’assicurazione e la sorveglianza, introducendo standard comuni e un meccanismo europeo di coordinamento tra autorità nazionali. Il rischio, infatti, è la creazione di un doppio livello autorizzativo: uno nazionale, regolato dalla Legge 89/2025, e uno europeo, disciplinato dal futuro Regolamento UE. Servirà un tavolo tecnico di allineamento, che consenta di preservare la centralità dell’ASI, senza sacrificare la flessibilità nazionale né ostacolare l’ingresso degli operatori nel mercato unico spaziale.
- Autorizzazione obbligatoria e tempi certi per gli operatori
L’articolo 4 della legge prevede che ogni attività spaziale – anche se svolta da operatori italiani all’estero – debba essere preventivamente autorizzata. Il rilascio dell’autorizzazione segue un iter strutturato: l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è incaricata di svolgere l’istruttoria tecnica, mentre il Comitato interministeriale per lo spazio e la ricerca aerospaziale (COMINT) esprime un parere vincolante. La decisione finale spetta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri o al Ministero delegato. I tempi per completare la procedura sono fissati in 120 giorni, ridotti a 60 se si applicano accordi di mutuo riconoscimento con Paesi terzi che dispongono di normative equivalenti. Per le attività a basso impatto, come gli esperimenti scientifici, è previsto un regime autorizzativo semplificato. Inoltre, per missioni interconnesse o costellazioni di satelliti può essere rilasciata un’unica autorizzazione cumulativa. In ogni caso, l’autorizzazione è subordinata al rimborso integrale dei costi istruttori e alla presentazione di una polizza assicurativa adeguata.
- Registro nazionale e responsabilità pubblica
La legge introduce un Registro nazionale degli oggetti spaziali, affidato all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), in cui devono essere iscritti tutti i manufatti per i quali l’Italia è considerata Stato di lancio, secondo quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1975. Il Registro ha pieno valore legale e si coordina con le comunicazioni obbligatorie verso l’ONU. A questo si affianca un Registro complementare dedicato agli oggetti acquisiti in orbita da soggetti italiani. Si tratta di strumenti rilevanti sia in termini di trasparenza, sia come fonte di prova in caso di controversie. La responsabilità per eventuali danni causati da oggetti spaziali segue un’impostazione “condizionata”: se l’attività è stata autorizzata e correttamente assicurata, l’operatore beneficia di una limitazione della responsabilità civile. Al contrario, in assenza di tali requisiti, la responsabilità diventa illimitata. Qualora lo Stato italiano fosse condannato in sede internazionale per un fatto imputabile a un soggetto privato, è previsto il diritto di rivalsa entro due anni.
- Il ruolo dell’ASI
La legge 89/2025 attribuisce all’Agenzia Spaziale Italiana un ruolo centrale nel nuovo assetto normativo dello spazio. L’ASI viene designata come autorità tecnica nazionale per la regolazione delle attività spaziali, con compiti definiti in materia di autorizzazione, vigilanza e gestione operativa. L’Agenzia è incaricata di curare l’intero procedimento autorizzativo: esaminerà le domande presentate dagli operatori, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, tra cui quelli tecnici, finanziari, assicurativi e ambientali. Sarà inoltre responsabile della tenuta e aggiornamento del Registro nazionale degli oggetti spaziali, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti a livello internazionale. La legge assegna all’ASI anche funzioni di vigilanza continuativa: l’Agenzia è tenuta a verificare la sicurezza delle attività spaziali, la resilienza informatica dei sistemi, le misure di mitigazione dei detriti orbitali e la gestione delle frequenze. A tal fine, può accedere alla documentazione, richiedere ulteriori informazioni e effettuare ispezioni nei luoghi dove si svolge l’attività autorizzata. Nei casi previsti, può proporre la sospensione o la revoca dell’autorizzazione. Nel complesso, l’impianto disegnato dalla legge consente di presidiare con maggiore efficacia l’accesso allo spazio extra-atmosferico, creando un quadro regolatorio più solido e funzionale anche all’ingresso di nuovi operatori, start-up e PMI, in un contesto di crescente apertura e competitività.
- Coperture assicurative e azione diretta del terzo danneggiato
Uno degli elementi più significativi della nuova legge è la previsione dell’obbligo di copertura assicurativa, disciplinato dall’art. 21. Ogni operatore autorizzato deve prevedere una polizza assicurativa o una garanzia equivalente il cui massimale, variabile in base al rischio dell’attività, non può comunque essere inferiore a 50 milioni di euro per sinistro. La soglia minima è ridotta a 20 milioni di euro nel caso di operatori che perseguano esclusivamente finalità di ricerca o che siano qualificati come start-up innovative. La normativa introduce inoltre l’azione diretta del terzo danneggiato contro l’assicuratore, che non può opporre nullità o estinzione del contratto e conserva il solo diritto di rivalsa. È consentita la coassicurazione e la stipula di coperture tramite consorzi riconosciuti da IVASS. Il sistema richiama da vicino i modelli già adottati in Francia e nel Regno Unito, ma introduce una maggiore rigidità quanto alla condizione di validità dell’autorizzazione, che decade automaticamente in assenza di copertura. Il modello si fonda quindi su una responsabilità parametrata al rispetto delle prescrizioni: solo l’operatore pienamente conforme può beneficiare della limitazione del danno. In tutti gli altri casi, anche in presenza di errore tecnico o di evento atmosferico, la responsabilità è totale, senza limiti massimali né esclusioni.
- Focus: la proposta della Commissione e gli impatti sul mercato unico
Le attività spaziali stanno conoscendo un’espansione rapida su scala globale, grazie a una crescente domanda di dati e servizi basati sullo spazio e alla riduzione dei costi di produzione e lancio dei satelliti. Tuttavia, le normative sviluppate dai singoli Stati Membri hanno condotto ad una frammentazione normativa all’interno del mercato unico europeo, in continuo sviluppo. Tuttavia, Le differenze nei criteri nazionali per la sicurezza, la resilienza e la sostenibilità ambientale delle infrastrutture spaziali possono avere impatti negativi sulla fornitura di dati e servizi spaziali nell’Unione. La proposta di Regolamento si pone l’obbiettivo di armonizzare la normativa nel settore aerospazio; con evidenti conseguenze anche lato economico. I benefici economici attesi sono considerevoli. Si prevede un risparmio di 68 milioni di euro in 10 anni grazie ad autorizzazioni comuni per le costellazioni e un guadagno annuo stimato di 1,3 miliardi di euro derivante dalla maggiore durata operativa dei satelliti. Inoltre, la riduzione dei rischi informatici potrebbe far risparmiare fino a 320 milioni di euro all’anno. Infine, l’armonizzazione normativa favorirà la nascita di nuovi mercati europei in settori innovativi come la rimozione dei detriti spaziali, la manutenzione in orbita e la crittografia, rafforzando la competitività industriale dell’UE.
- Conclusioni
La legge 89/2025 rappresenta per l’Italia un traguardo atteso, che introduce una disciplina organica per l’accesso e la gestione delle attività spaziali. Con la proposta di EU Space Act, presentata dalla Commissione europea il 25 giugno 2025, si apre ora una fase di progressivo consolidamento del quadro normativo a livello europeo. Resta da valutare come si integreranno le competenze nazionali con le future disposizioni europee in materia di autorizzazione, vigilanza e sicurezza, per evitare sovrapposizioni regolatorie e garantire un’efficace coerenza tra i diversi livelli di governance.